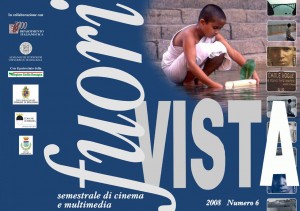Lavorare nel cinema non significa soltanto recitare su un set o stare dietro una macchina da presa; si tratta di un mondo ben più ampio, che assimila e racchiude milioni di sfaccettature e le trasforma nelle tante professioni del cinema. E, allo stesso modo, non esistono soltanto registi, attori, cinematografie universalmente conosciuti; spesso accade invece che proprio qui, in ciò che intenzionalmente o involontariamente trascuriamo, si nascondono i piccoli capolavori.
L’obiettivo principale di FuoriVista è dunque quello di essere un luogo in cui coloro che di solito non hanno voce in capitolo, possano raccontare la loro esperienza, fatta di risultati ma spesso anche di grosse difficoltà. Sono quelle che amiamo definire le concretezze del fare cinema: tutte quelle azioni, quelle mansioni che, date di frequente per scontato, difficilmente vengono prese in considerazione da parte dello spettatore, proprio perché manca una reale e profonda conoscenza del loro funzionamento. Per questo motivo, Fuori Vista vuole essere uno strumento di effettiva utilità, da ogni punto di vista: di chi produce, di chi riceve e di chi sta in mezzo e fa da tramite tra il momento creativo e quello fruitivo.
Conversazione con Hugues Sheeren, docente di francese (“lettore di scambio”) presso l’Università di Bologna
di Donatella Stinga e Maria Paola Meloni.
Il Dott. Sheeren è presidente dell’Associazione culturale italo-belga “Bologna-Bruxelles A/R” e promotore della cultura belga attraverso le attività organizzate dal “Centre d’études sur la littérature belge de langue française” (ceSLeBeLF). Lo abbiamo incontrato nel corso della rassegna “SIMENON CINÉMA – L’adattamento dei gialli del romanziere belga al grande schermo – Mostra di manifesti e fotografie” che si è tenuta a Bologna nel gennaio 2009.

“Quando abitavo a una dozzina di km da La Rochelle, presi l’abitudine di andare ogni sabato in uno dei cinema popolari che proiettavano due film a serata, senza contare i lunghi intermezzi durante i quali gli spettatori si assiepavano nel bistrot appartenente allo stesso proprietario (che rendeva economicamente più dei film). Non parlerò di quei film. Come qualità corrispondevano più o meno ai romanzi popolari che scrivevo, sforzandomi di rimanere in tono e di far ridere o piangere al momento giusto. Quello che mi attirava era la folla che reagiva ammirevolmente a tutte le piccole astuzie degli autori. Amavo anche lo stare gomito a gomito con gente con cui mi sentivo solidale e come gli altri andavo a bere il mio boccale di birra durante l’intervallo”. (Da W+B, Octobre 2002,Georges Simenon le théâtre et la chanson di Marc Danval, p. 48)
PREMESSA
Simenon è tuttora lo scrittore al mondo più adattato al cinema. Dai suoi romanzi sono stati tratti 58 adattamenti per il grande schermo e una novantina di serie per le televisioni di tutto il mondo, con nel ruolo di protagonista il commissario Maigret, suo celeberrimo personaggio.
A 20 anni dalla morte di Simenon, e a 35 anni dalla morte di Gino Cervi, grande interprete televisivo di Maigret in Italia, a Bologna, città natale di Cervi, ha avuto luogo la rassegna “Simenon Cinéma”, organizzata dall’Associazione culturale italo-belga “Bologna-Bruxelles A/R” e dal “Centre d’études sur la littérature belge de langue française” del Dipartimento di Lingue e Letterature straniere dell’Università di Bologna, insieme al Quartiere Santo Stefano, alla Cineteca di Bologna e con la collaborazione di Wallonie-Bruxelles International (Comunità francofona del Belgio), Fondazione Federico Fellini, il Centre d’Etudes Georges Simenon dell’Università di Liegi, e il sostegno di Erasmus Mundus Program (CLE) e dell’ufficio Belga per il turismo Vallonia-Bruxelles. La rassegna ha incluso conferenze, esposizioni e proiezioni cinematografiche.
FUORIVISTA ha incontrato il dott. Hugues Sheeren, il quale ci ha cortesemente illustrato l’esposizione allestita al Baraccano nel contesto della rassegna.
La mostra ha ospitato parte della cartellonistica cinematografica dei film di Simenon, proveniente dalla collezione del belga Michel Schepens, ma anche parte della sua corrispondenza epistolare e reperti legati alla sua pratica della scrittura, provenienti dal fondo Georges Simenon dell’Università di Liegi, assieme a una collezione di foto di scene tratte dai film, esposta al Cinema Lumière che ha ospitato una rassegna cinematografica dedicata all’autore.
D. Come è nata la decisione di organizzare questa rassegna?
Sono trascorsi venti anni dalla morte di Simenon e questo anniversario coincide con il trentacinquesimo anno dalla morte di Gino Cervi, grande interprete televisivo di Maigret in Italia. Non a caso è stato scelto di organizzare questa manifestazione, a Bologna, città natale di Cervi.
Liegi, dove nacque Simenon, e Bologna, sono in qualche modo predisposte al poliziesco per via della configurazione stessa delle città. Bologna ha sempre avuto quest’aura, e molti autori di romanzi polizieschi vi hanno ambientato le loro storie (come Bernardi, Lucarelli, Machiavelli n.d.r).
Sheeren inizia con l’illustrarci la parte della mostra proveniente dal Fondo Simenon, relativa alla sua pratica della scrittura .
Ecco le famose buste gialle. Simenon aveva questo rituale nella scrittura: la macchina da scrivere, le buste gialle, le matite ben temperate, era un po’ superstizioso…
Abbozzò il suo primo romanzo su una busta gialla, utilizzata come canovaccio, e da quel momento l’ha sempre fatto. Sulla busta scriveva il titolo e poi la carta d’identità dei personaggi: età, caratteristiche, stato civile, città e altre informazioni. A volte era molto più dettagliato e tracciava anche la pianta di una città. Si ispirava sempre ai fatti reali della sua vita, non riusciva a inventare, doveva rifarsi a qualcosa che aveva conosciuto.
Simenon ha scritto tantissimo, si parla di 450 romanzi circa. All’inizio della sua carriera scrisse romanzi a sfondo erotico: la definiva letteratura alimentare, perché scriveva per vivere. Era consapevole che si trattava di una letteratura di poco valore, ma piuttosto congeniale a un pubblico di casalinghe, un po’ alla Barbara Cartland.
Nonostante fosse uno scrittore così prolifico, è strano considerare come anche nelle sue memorie abbia raccontato di quanto fosse difficile per lui scrivere, di come a un tratto, nei giorni che precedevano la scrittura, sentisse un sorta di disagio, malessere, quasi di nausea.
Si chiudeva allora in una stanza. Si diceva che nessuno l’avesse mai visto scrivere, fatto confermato dal figlio, John.
D. Nei romanzi spesso Maigret cammina molto, lo si potrebbe definire un flâneur… gli piace perdersi nella città che diventa una vera e propria protagonista del romanzo… come Parigi…
Sì, Parigi e non solo. Maigret, che a mio avviso forse non è molto intelligente, ha però fiuto, una grande intuizione. Per cui ha bisogno di ambientarsi nei vicoli, nei bar, per capire gli odori, i suoni, e comprendere, identificarsi anche con il criminale e con la vittima. Per questo in effetti ha bisogno di andare un po’ a zonzo…
D. Oggi lo si potrebbe definire quasi un profiler?
Si, vero… Proseguendo nel nostro percorso, qui abbiamo un albero genealogico. È alla base di Pedigree, il grande romanzo autobiografico di Simenon, anche se in realtà i nomi sono stati cambiati perché lo scrittore voleva evitare conseguenze legali.
Nel 1940 un medico gli annunciò che gli rimanevano solo due anni da vivere. La diagnosi era completamente falsa, però sul momento per lui fu ovviamente uno shock; aveva appena avuto il primo figlio, Marc, e si era detto: «Ma se muoio, mio figlio non saprà niente di me». Allora tracciò il suo albero genealogico, dopodiché iniziò a scrivere questo romanzo, che all’inizio si chiamava Je me souviens.
Dopo capì che non sarebbe morto, ma portò comunque avanti il romanzo.
La critica lo attendeva al varco, avendo Simenon fino a quel momento prodotto tutta quella letteratura o popolare o poliziesca con Maigret. Poi infatti abbiamo i romanzi duri, come li chiamava lui, dei polizieschi senza Maigret, il quale d’altronde è presente solo in circa un terzo dei suoi romanzi.
La critica si aspettava un romanzo vero, alla Balzac… Gide spinse Simenon a pubblicare Pedigree e l’albero genealogico fu alla base di questo romanzo, lo fece per ricordarsi…
D. A proposito di Balzac, spesso è stato fatto un accostamento tra Simenon e Balzac, sia per la prolificità della loro scrittura, sia per il forte desiderio di fama e riconoscimento da parte del pubblico. Anche l’intento di penetrare nell’intimo dei personaggi, di riuscire a rendere l’umanità di un personaggio marginale li accomuna…
Si è vero, sono stati paragonati anche perché Balzac, come Simenon, diceva «Je veux tout voir, tout comprendre». C’era in lui la volontà di non tralasciare niente di ciò che c’era nell’universo, e anche in Simenon c’è questa componente. Quasi una forma di bulimia, come può qualcuno scrivere così tanto? È pazzesco!
Simenon diceva sempre di avere avuto 10.000 donne, fu una sorta di don Giovanni; e anche in altri campi dimostra questa volontà di impadronirsi di tutto. Anche Balzac provava questi sentimenti, questo desiderio di rappresentare tutto, di non perdere niente.
Simenon lo dimostra anche con i suoi viaggi in giro per il mondo, non voleva lasciar perdere niente…
D. Ha viaggiato molto attraverso fiumi, mari…
Sì, raccontava sempre che fu sulla sua imbarcazione che nel 1929 inventò Maigret, a Delfzijl, un piccolo porto nei Paesi Bassi… che poi in fondo è un mito anche questo, il mito della nascita del suo personaggio. In realtà molti critici sostengono che ciò non sia vero, che Maigret sia stato creato un po’ di tempo prima, che alcuni dei suoi tratti fossero già in altri suoi personaggi.
D. Un giramondo che poi per scrivere si rinchiudeva in una stanza.
Simenon era pieno di contraddizioni, tendeva a esagerare le cose. Non so se conoscete l’aneddoto, Le bal anthropométrique, il famoso ballo in maschera, una propaganda per lanciare Maigret. Per questo ballo gli inviti erano delle finte schede giudiziarie e gli ospiti, arrivando, dovevano lasciare le impronte digitali, c’erano finti cadaveri e poliziotti, tutto questo per suscitare scandalo, rumore, scalpore.
Poi negli anni Venti ci fu il famoso episodio della gabbia di vetro. Un editore pensò di rinchiuderlo in una gabbia di vetro, in una piazza, dove avrebbe dovuto scrivere un romanzo sotto gli occhi di tutti, cosa che non ha mai fatto. Simenon fu accusato di essere uno scrittore “à la minute” All’ultimo momento la cosa non si fece a causa di tutta la polemica che si era creata, comunque molta gente disse di averlo visto scrivere nella gabbia, e si sono poi create leggende attorno a tutto ciò. Quest’episodio, però, gli nuocque per il resto della sua carriera.
Proseguendo, volevo mostrarvi i calendari, un’altra delle sue “superstizioni”: Simenon prendeva sempre gli stessi calendari e faceva delle crocette blu sui giorni in cui scriveva e delle crocette rosse sui giorni corrispondenti alla correzione, alla revisione, ma a volte gli capitava di invertire i colori. Questo denota il suo lato metodico: era estremamente puntiglioso, ma allo stesso tempo un po’ pazzo.
D. Il titolo della rassegna in francese gioca sull’assonanza Simenon/Cinéma.
In realtà, nonostante la grandissima mole di adattamenti cinematografici tratti dai suoi libri, non è così vero che Simenon abbia avuto un fortissimo rapporto con il cinema. Non ci andava, perché soffriva di claustrofobia, né ha mai scritto sceneggiature. In verità ci provò, ma deluso dai primi adattamenti, non fece mai film.
D. Eppure il primo Maigret cinematografico è il film di Renoir, del ‘32. Come pensa che lui abbia vissuto l’esperienza di questo primo film proprio con Renoir?
Pensavo infatti a questo caso. Ci sono stati tre film tratti da Simenon negli anni Trenta: La nuit du carrefour di Jean Renoir (La notte dell’incrocio, 1932) con il fratello Pierre Renoir, Le chien jaune di Jean Tarride e Il delitto della villa di Julien Duvivier (1932), dal romanzo La tête d’un homme.
Simenon rimase deluso, non tanto dai film in sé, perché quello di Jean Renoir è molto bello, ma il regista ebbe strane vicissitudini: aveva perso la moglie e si ubriacava spesso, così si dimenticò di girare alcune parti, si sono perse delle bobine con una parte del film e anche della sceneggiatura. Quindi un film incomprensibile, che però risulta molto bello, poiché Renoir era riuscito a cogliere l’atmosfera.
Simenon parlava di clima, non di atmosfera. Preferiva clima, forse per il clima belga, non so…
Comunque rimase deluso dall’esperienza cinematografica. Così negli anni Trenta decise di voler girare personalmente dei film, bloccando tutti i diritti di adattamento cinematografico delle sue opere per sei anni, perché riteneva che i produttori non avevano fatto abbastanza pubblicità. Disse che nessuno avrebbe ancora potuto creare film tratti dai suoi romanzi, ma è una delle tante bugie che ha raccontato, perché in realtà nel 1939 cambiò idea ed ecco che i suoi romanzi saranno adattati di nuovo sul grande schermo.
Sheeren prosegue mostrandoci i manifesti cinematografici dei film tratti da Simenon, provenienti dalla collezione Schepens. I manifesti belgi hanno la doppia didascalia in francese e olandese. Lo stesso film ha titolo e locandine diverse a seconda del paese.
Per i manifesti, noi abbiamo parte della collezione Schepens: questi provengono dalla Comunità francofona del Belgio (Wallonie-Bruxelles International), gli originali li ha il collezionista.
Quando sono scomparsi i cinema di quartiere, con la nascita della televisione, alcune persone hanno pensato di cominciare a collezionare i manifesti, perché si rendevano conto del loro valore artistico. Questi artisti erano in genere anonimi. Alcuni facevano delle collezioni in base a un tema, ad esempio il tema del treno nel cinema oppure uno strumento musicale o un attore in particolare, e raccoglievano le locandine in base a questi elementi.
Il nostro collezionista ha scelto di raccogliere i manifesti relativi ai film di Simenon che gli ricordavano l’infanzia, quando li vedeva per strada. In Belgio, una volta, le locandine non venivano affisse solo al cinema come oggi, ma anche per strada, nei bar, nei negozi, e anche nelle case dei privati, alle finestre.
Chi accettava di esporre le locandine riceveva dei biglietti in omaggio.
In Belgio le locandine erano più piccole di queste esposte, mentre in Francia e in Italia avevano più o meno la stessa dimensione. In Belgio erano più piccole (ripetizione), soprattutto durante la guerra, perché in mancanza di carta, spesso venivano utilizzate cartine militari, tagliate in quattro parti e stampate sul retro.
Si può anche notare che molti di questi film vennero prodotti dalla casa di produzione Continental, francese ma controllata dai tedeschi, fatto che causò non pochi problemi a Simenon negli anni Quaranta, perché durante l’occupazione tedesca sono usciti nove film di Simenon, non solo con protagonista Maigret, prodotti dalla Continental. Questo fu motivo di critica, in quanto, nel corso del conflitto, lo scrittore condusse una vita da borghese, in campagna. Ha avuto un atteggiamento un po’ opportunista, ambiguo…
Tuttavia è anche vero che in quel periodo il suo dottore gli aveva annunciato che gli restava poco da vivere. Questo può essere stato il motivo per cui scelse di mettersi un po’ da parte. Nel 1945 ci furono delle indagini su di lui, ma non si è mai scoperto niente e questi film non veicolavano alcun messaggio di propaganda, per cui non c’è nessuna prova che Simenon abbia anche solo vagamente collaborato con i tedeschi, però questo è il motivo per cui alla fine andò via e si trasferì negli Stati Uniti.
A mio avviso in quei film ci fu un errore nella scelta di far interpretare Maigret ad Albert Préjean, perché era un attore in voga in quel periodo. Era sul tipo del seduttore, troppo giovane per interpretare Maigret.
A proposito degli interpreti di Maigret, questa è una marionetta molto carina che ha fatto un artista bolognese su Gino Cervi che incarna Maigret.
D. Maigret ha avuto molti, diversi interpreti. Che pensa dell’interpretazione di Maigret data da Gino Cervi? Conosce la versione televisiva? E del Maigret di Michel Simon?
Sì, conosco Maigret a Pigalle di Mario Landi (1966), tratto da Maigret au Picratt’s, una coproduzione franco-italiana, l’unico film italiano su Maigret al cinema e l’ultima versione cinematografica del personaggio.
La serie televisiva italiana iniziò nel 1964. Tra l’altro, dalla corrispondenza con Fellini, si evince che Simenon apprezzasse molto l’interpretazione che Gino Cervi diede di Maigret.
D’altronde – non solo in Italia – ciò che ha reso veramente popolare il personaggio di Maigret è stata la televisione, più che il cinema. Dal 1967 in poi le trasposizioni cinematografiche di Simenon riguardano gli altri suoi romanzi, non più i Maigret.
Simenon amava poi molto l’interpretazione di Michel Simon, che purtroppo ha fatto solo un film, Brelan d’as di Henri Verneuil (1952).
Tra gli attori che hanno interpretato Maigret, ricordo anche Pierre Renoir, primo Maigret sullo schermo, il quale ne diede una bella prova.
D. Dopo la guerra arrivano i primi adattamenti stranieri da Simenon. Film americani, tedeschi, austriaci.
A volte ci sono anche due film diversi ispirati allo stesso romanzo, che non hanno neanche lo stesso titolo. Ci sono 53 film tratti da una quarantina di romanzi, perché a volte abbiamo due o tre adattamenti dallo stesso romanzo iniziale. Penso a Les fiançailles de M. Hire, arrivato in Italia con il titolo L’insolito caso di Monsieur Hire, del 1990, già realizzato negli anni Cinquanta con il titolo Panique, con Brigitte Bardot.
D. Maigret, un detective francese, ma dallo spirito belga!
Credo che in un’atmosfera surrealista, tipicamente belga, vi sia un parallelo tra il pittore Magritte, anche lui belga, e la pipa che caratterizza Maigret… Maigret è francese, ma in fondo è un po’ belga, perché è un uomo che tace.
Il silenzio pervade la cultura belga, ha qualcosa a che fare con un complesso linguistico nei confronti dei francesi che hanno sempre considerato altezzosamente i belgi per via del loro accento.
Il tema del silenzio si trova poi nel cinema belga, nella letteratura simbolista, nei fumetti, nella scrittura.
Maigret è un personaggio molto taciturno e Jean Gabin è stato talvolta criticato perché parlava troppo nei film. Maigret rappresenta anche il francese medio, quindi un personaggio anonimo, senza grande carisma, non bello, non simpatico, in fondo senza una chiara personalità.
Però ha la sua pipa, l’impermeabile, la bombetta che lo caratterizzano, e proprio in quegli anni, Magritte dipinge le sue pipe, per cui si può dire che la pipa di Maigret è magrittiana e maigrettiana al tempo stesso.
D. Anche Poirot, l’investigatore creato da Agata Christie, è belga…
Si, e né lui né Maigret sono dei James Bond! Prevale in loro il lato riflessivo, sono dei personaggi tutto sommato “modesti”, anche se poi sanno di valere… Non sono eroici come dei James Bond, insomma, né come degli Sherlock Holmes.
D. Neanche degli Auguste Dupin, il detective di Poe.
Già. Penso che la modestia sia un tratto tipicamente belga. Il Belgio è un piccolo paese, che non ha la grandeur francese…
La paura di commettere degli errori nella lingua ha spinto i Belgi a orientarsi verso la grammatica, nella quale primeggiano, a un punto tale che i Francesi si riferiscono a delle grammatiche scritte da Belgi.
Il cinema belga ha faticato ad affermarsi rispetto a quello francese, che lo ha sempre un po’ schiacciato, anche se ultimamente ha iniziato a farsi conoscere. In ambito letterario, il Belgio si è espresso per questo motivo soprattutto nella para-letteratura, nel poliziesco, nel fantastico e nei fumetti, generi per così dire “paralleli”. La Francia non riconosceva questi generi. È per questo che Simenon era considerato uno scrittore di “basso livello”, perché la sua non era reputata “letteratura”. La para-letteratura è stata a lungo oggetto di pregiudizio e tutt’oggi Simenon fa fatica a entrare nei programmi universitari in Francia, poiché vi è ancora un certo pregiudizio.
D. In Francia l’interprete principale di Maigret è stato Jean Gabin.
Nel ’56 Gabin interpretò per la prima volta il ruolo di Maigret. Gabin era già apparso in alcuni film tratti dai Maigret, ma non nel ruolo del commissario. Alcuni critici letterari affermano che nel ’58 si riuniscono i due miti, perché Gabin era già un mito negli anni Trenta in Francia e Maigret è un mito dagli anni Trenta in poi.
Gabin non avrebbe potuto rappresentare Maigret in quell’epoca perché era troppo giovane; alla fine degli anni Cinquanta i due miti si incontrano, anche perché Gabin ha raggiunto un’età più consona a quella di Maigret, che, quando nasce all’inizio degli anni Trenta ha 45 anni, e quando Simenon lo abbandona ne ha 53.
Lo scrittore aveva quaranta anni in più, e il suo personaggio era invecchiato di setto-otto anni al massimo.
Gabin recitò in tre film, tra cui un non Maigret, En cas de Malheur (La ragazza del peccato, 1957 di Autant-Lara) con Brigitte Bardot.

Questo invece è il manifesto di Trois Chambres à Manhattan (Marcel Carnè, 1965), dal romanzo che traduce la sua esperienza americana. Il figlio ha affermato che Simenon aveva qualcosa tipico dell’autore americano, ma io non sono d’accordo. Francofono, nato in Belgio, morto in Svizzera, vissuto in Francia e sposato con una donna del Quebec. Si potrebbe pensare addirittura che incarni la francofonia. Al contrario si dovrebbe affermare che Simenon è uno scrittore universale, del mondo, che non si può facilmente collocare in una nazione precisa.
Comunque chi conosce il Belgio, e in particolare Liegi, ritrova pienamente la sua atmosfera nelle descrizioni che Simenon fa di Parigi, dei suoi bar, dei suoi angoli.
D. Simenon fu anche grande amico di Fellini.
La storia con Fellini è molto bella. Inizia a Cannes nel ’60, quando Fellini era in concorso con La Dolce Vita e Simenon era presidente della giuria. Simenon difese Fellini, voleva che vincesse la Palma d’oro.
Nessuno voleva premiare Fellini: c’erano delle pressioni diplomatiche, delle persone nella giuria, che in teoria non dovevano trovarsi lì, cercarono di influenzare il verdetto. Simenon difese strenuamente Fellini, assegnandogli il premio nonostante i fischi del pubblico. Da lì nacque la loro amicizia.
Si sono scritti per oltre 20 anni. La loro corrispondenza è stata pubblicata in Italia da Adelphi.In realtà si conoscevano già da un po’, o meglio, si ammiravano. Fellini ha sempre apprezzato le atmosfere e il clima in Simenon, e anche Simenon apprezzava i suoi film, nonostante andasse poco al cinema.

Qui abbiamo la fortuna di vedere due caricature fatte da Fellini, una proprio di Simenon – dal Libro dei sogni – e una del commissario Maigret, provenienti appunto dalla fondazione Fellini. (Entrambe le immagini sono sul depliant dell’evento, reperibile al sito: www2.lingue.unibo.it/centrobelga/_Pieghevole-1.pdf)
Simenon e Fellini si scrivevano in tre lingue, italiano, francese e inglese. Ognuno aveva una conoscenza passiva della lingua dell’altro. Insomma, erano degli uomini di livello internazionale e si sono scritti tanto.
In qualche modo si consideravano dei fratelli, ma la loro fu un’amicizia molto epistolare, non si vedevano quasi mai. Però nelle lettere traspare dell’affetto, una condivisione delle proprie esperienze, anche nei momenti di incertezza.
D. Pare che Simenon abbia incoraggiato Fellini a realizzare Il Casanova.
Sì, qui abbiamo una lettera molto interessante, dove Fellini racconta di aver sognato Nettuno. Leggendola abbiamo riso perché il Nettuno è il simbolo di Bologna ma di fatto il suo realizzatore si chiamava Jean de Boulogne, ed era fiammingo; la copia del Nettuno si trova a Bruxelles.
Fellini raccontò che il sogno lo aveva influenzato nella decisione di realizzare Il Casanova.
Qui c’è una foto di Liegi, la Liegi dell’epoca, dove c’è proprio il “Percorso Simenon” da fare a Natale, una moda molto bella che è nata negli ultimi 15 anni
Nel quartiere di Outremeuse, c’è la sua statua, oltre a molte sculture di personaggi che hanno fatto la storia. Liegi è la città natale anche di Carlo Magno.
I passanti si abituano e imparano a conoscere questi personaggi che spesso abbiamo dimenticato.
Ma Simenon, non è stato dimenticato. Infatti a Liegi, nel quartiere Outremeuse si vive ancora con il suo ricordo. Questo è il Pont des Arches, che fa da sfondo al suo primo romanzo, la casa dove ha vissuto e anche certe insegne dei negozi, sono come allora.
D. Un altro grande artista belga è Jacques Brel. Brel e Simenon, in modi diversi, hanno stigmatizzato una certa ipocrisia borghese, una certa religiosità di facciata nella società belga. Simenon scrisse che quando ascoltava Le plat pays non poteva fare a meno di piangere. Pensa si fossero conosciuti?
Non penso… Sono due persone che hanno lasciato il Belgio per fare carriera a Parigi e solo questo hanno in comune. Poi Simenon ha vissuto negli Stati Uniti, e in seguito in Francia, ma non più a Parigi.
Avevano 26 anni di differenza… Anche se poi Brel è morto prima di Simenon.
Credo che l’uno conoscesse il lavoro dell’altro, ma che non ci fossero stati tra loro dei contatti diretti.
Maria Paola Meloni – Donatella Stinga
INTERVISTA: “DIVERSAMBIENTE”. Al cinema biodiversamente
di Donatella Stinga.
Centro Documentazione Handicap di Bologna
e Parco dell’Abbazia di Monteveglio.
«The great art of films does not consist of descriptive movement of face and body but in the movements of thought and soul transmitted in a kind of intense isolation».
«La grandezza del cinema non consiste nel descrivere i movimenti del volto e del corpo, ma i moti del pensiero e dell’anima trasmessi in una sorta di intenso isolamento».
Louise Brooks (1906 – 1985), attrice.
Una prima riflessione:
La straordinarietà del cinema è il voler raccontare storie, vere o inventate, e a chi interessa se i protagonisti sono “normali”, disabili o magari pinguini…
L’importante è che la storia catturi le nostra capacità percettive.
Il cinema ha trattato in vari modi le tematiche della disabilità, dal 1923 con il Gobbo di Notre Dame di Wallace Worsley a Il mio piede sinistro di Jim Sheridan nell’89, con il bravissimo Daniel Day-Lewis; da
Forrest Gump (1994) di Robert Zemeckis (chi non ricorda la frase: “Stupido è chi lo stupido fa!”) a L’ottavo giorno (1996) di Jacob Van Dormael.
La rappresentazione della disabilità attraversa l’immaginario cinematografico.
Grazie anche al cinema, e alla potenza delle sue immagini, si è potuto mostrare, rappresentare la persona disabile nella ricchezza e nella concretezza del suo stesso corpo, talvolta vissuto come tabù.
Attraverso il cinema si ha la possibilità creativa di relazionarsi con mondi diversi e quindi modificare i propri punti di vista, entrando in empatia con il paesaggio interiore di personaggi all’apparenza irriducibilmente altri.
Negli anni Trenta un regista, Tod Browning, osò portare sullo schermo i freaks (concepiti precedentemente come fenomeni da baraccone), svelandoceli nella loro umanità.
Nel film di Browning è chiaro che ci sono essere umani “mostruosi” che possono avere sembianze gradevoli, mentre chi ha avuto il destino di essere diverso nell’aspetto e nelle capacità fisiche, può avere una comprensione più vasta della condizione umana.
Il cinema in questo ci ha aiutato ad aprirci e a guardare con occhi nuovi l’apparente bellezza o bruttezza delle cose, e ad affrontare il disagio dell’insolito, per riconoscerci in quei personaggi marginali che portano spesso il peso dell’esclusione sociale.
L’INTERVISTA
Inoltre, la redazione di Fuorivista ha deciso di incontrare alcuni animatori del Centro Documentazione Handicap di Bologna per ragionare con loro delle problematiche connesse ad un loro interessante progetto.
Cornice dell’incontro è il Parco dell’Abbazia di Monteveglio con il quale il CDH sta creando “Diversambiente” del quale ci appunto ci parleranno.
Facciamo quindi la conoscenza di Roberto, educatore del Progetto Calamaio – Cooperativa Accaparlante – Stefania e Matias, due animatori, e Daniela De Matteis, coordinatrice delle visite guidate e del turismo scolastico all’interno del Parco dell’Abbazia.
FV (Donatella Stinga) – Come è nato il progetto “Diversambiente”?
Daniela De Matteis – L’idea è nata da Paolo Degli Esposti che lavora al Centro Documentazione Handicap di Bologna e vive a Monteveglio. Conoscendo perfettamente la realtà del parco, ha pensato di costituire una rete tra varie realtà locali, ognuna con le proprie esperienze. Ha coinvolto così il CDH, la cooperativa “La Valle del Lavoro”, il Centro di Documentazione per l’Integrazione di Crespellano, che funge da collegamento tra persone e realtà coinvolte sui temi dell’integrazione; e infine l’Associazione Volhand la quale riunisce famiglie con figli disabili.
L’idea era quindi quella di creare un contesto sia materiale, nello specifico un Giardino del Benessere, sia formale, ossia un luogo in cui valorizzare le diverse competenze e abilità, un “luogo del fare” come mi piace chiamarlo. Abbiamo pensato al giardino come a uno spazio nel quale, con determinate accortezze, poter accogliere persone anche disabili al fine di svolgere attività in campo naturalistico. All’interno del parco, infatti, sono presenti piante, animali e situazioni geologiche interessanti che però, per la natura stessa del parco, sono difficili da visitare per chi ha difficoltà motorie.
FV – A questo proposito, Monteveglio è un piccolo scrigno di biodiversità, grazie alla varietà di ambienti che caratterizza il parco.
Daniela – Senza dubbio. Il parco rappresenta un mosaico ambientale molto ricco, che testimonia lo storico intreccio tra dinamiche naturali e interventi umani. In circa mille ettari si assiste a una grande diversità ambientale, quindi di specie. In particolare, tra le zone più rinomate del parco spiccano alcuni bacini calanchivi nei quali affiorano le rocce più antiche dell’Appennino bolognese. Queste zone sono tipiche dei nostri territori. Ma il fiore all’occhiello di Monteveglio è l’abbazia, circondata dall’abitato medievale sorto intorno all’antichissima pieve di Santa Maria. La particolarità che però voglio sottolineare è che già dagli anni Ottanta le scuole svolgevano progetti di educazione ambientale, uscendo sul campo, studiando la natura dal vivo e non sui libri, sebbene il parco non esistesse formalmente come istituzione. Quando perciò nel 1995 venne istituito, già da molto tempo era noto alle comunità e amministrazioni locali per la sua forte vocazione didattica.
FV – Roberto, tu sei educatore del Progetto Calamaio. Come è nata l’unione tra il gruppo di Accaparlante e il Parco di Mointeveglio?
Roberto – Il progetto “Diversambiente” nasce a seguito dell’ampliamento della rete di cui ragionavamo prima con Daniela. Fin dall’inizio per noi è stata una sfida tentare di mettere in contatto la nostra esperienza con quella del parco, per cui cercare un aggancio tra la diversità delle persone con quella della natura.
FV – Ma partivate favoriti per via del Progetto Calamaio.
Roberto – Si può dire che abbiamo fatto degli esperimenti, iniziando a entrare nelle classi e seguendo i percorsi già avviati dal parco per vedere la reazione dei bambini e scoprire i possibili punti di contatto. Abbiamo impiegato il parco e un percorso preesistente per ideare un’animazione volta a far comprendere la diversità ai bambini. Ciò soprattutto in vista della realizzazione del Giardino del Benessere. Abbiamo perciò intrapreso un cammino di ricerca con educatori, animatori, responsabili del parco e bambini. Il nostro intento era che le idee per la realizzazione del Giardino nascessero dai bambini per far sì che questo luogo non fosse il giardino dei disabili, ma di tutti. La nostra idea era di concepire un percorso adatto sia a una persona in carrozzina sia alla mamma che viene col bambino in passeggino, sia a una persona che non riesce a deambulare bene sia a un anziano…
Daniela – Per esempio dal sentiero che verrà costruito si vedono i calanchi di per sé difficilmente accessibili a tutti per via del fango e del forte dinamismo che li caratterizza. Allora i bambini hanno avuto l’idea di portare dell’argilla, di cui sono fatti i calanchi, vicino al sentiero, in modo tale che la pioggia creasse dei piccoli calanchi. I bambini hanno perciò ragionato su come dare la possibilità a una persona disabile di toccare con mano i calanchi.
Roberto – La prima parte del progetto è stata di ricerca, di confronto e anche di grande divertimento perché la nostra modalità operativa è proprio questa: lavorare su tematiche profonde, ma sempre attraverso le storie e il contatto giocoso con i bambini.
FV – Quali sono i metodi didattici impiegati nel Progetto Calamaio?
Stefania – Nel Progetto Calamaio utilizziamo in particolare la fantasia: c’è chi ha la fantasia di inventare delle fiabe, c’è chi, come me, ha la fantasia per disegnarle. Però le nostre fiabe hanno qualcosa di diverso. Inoltre creiamo i costumi adatti per portarle in scena nelle classi.
Roberto – Nel Progetto Calamaio ognuno mette in gioco le proprie abilità. Quando per esempio è arrivata Nadia ha introdotto il problema della ipovisione. Questo è stato uno stimolo a creare dei costumi tattili per non limitare il tutto a una dimensione visiva. È proprio così che il progetto si rinnova di volta in volta.
FV – Collaborate con classi che vanno dalle elementari alle superiori, come reagiscono gli alunni?
Roberto – Il punto forte del Progetto Calamaio è proprio quello di incontrare i ragazzi non raccontando l’esperienza ma facendogliela fare: non spieghi che cos’è la disabilità, chi è una persona disabile, qual è la sua storia. Al contrario, incontri la persona, la disabilità, la carrozzina, le difficoltà, incontri una storia vera. Da una parte, questo comporta un primo momento di imbarazzo da parte dei bambini, ma è proprio da lì che partiamo, da questa difficoltà, e su di essa procediamo perché altrimenti si rischia di lavorare in maniera astratta. Ovviamente, non vogliamo mettere di proposito le persone in difficoltà, ma visto che i limiti e le fatiche esistono è da lì che partiamo, per dimostrare che non è una cosa brutta. A questo punto il bambino conosce la persona e va oltre la disabilità che diventa parte dell’identità della persona.
FV – Forse c’è più imbarazzo da parte degli adulti che non dei bambini?
Roberto – Effettivamente sì!, incontriamo maggiore imbarazzo negli adulti e nei ragazzi più grandi. I bambini, invece, non provano imbarazzo, forse più timore o difficoltà a guardare il disabile, ma dall’altra parte una grande spontaneità. È questo alla base del Progetto Calamaio: incontrare una persona e superare la disabilità per ridurla a una parte.
FV – In questo modo si sottolineano le abilità, non la disabilità.
Roberto – Certo, a noi piace lavorare sulla relazione, sul contatto, sul confronto. Hai un animatore disabile con la propria storia, la presenza fisica e il limite della carrozzina che diventa spesso un gioco.
Stefania – La carrozzina non è più un pezzo di ferro freddo come poteva essere visto una volta…
Matias – Volevo aggiungere che viviamo in una società che tende a omologare. Invece lavorare sulla diversità, con i bambini soprattutto, porta a valorizzare la diversità così da diventare una ricchezza.
Roberto – L’altro strumento che impieghiamo è il gioco di ruolo attraverso cui si sperimenta un limite, non vedere, non muoversi, non parlare, per esempio. Solo così vivi cosa sente l’altro.
Daniela – In termini di metodologia, nei programmi di educazione ambientale, si utilizzano le stesse modalità. La finalità è quella di percepire in natura cose che normalmente non percepiamo.
Per esempio la vista è il senso che più utilizziamo, ma spesso oscura gli altri sensi. Anche a noi capita di bendarci per cercare di cogliere meglio i suoni dell’ambiente.
FV – Si è creata perciò una sinergia tra voi del parco e i ragazzi del Calamaio.
Daniela – Sì, infatti c’è molta affinità per quanto riguarda la comunicazione e le modalità di approccio con i bambini. Non ho mai notato una differenza, anche se veniamo da esperienze completamente diverse. Gli stessi insegnanti non badavano se in classe intervenivo io o Roberto, Matias o Stefania.
FV – Ritenete che ci siano ancora dei pregiudizi riguardo la disabilità?
Stefania – Sicuramente credo ce ne siano ancora, ma sono molto diminuiti. Però c’è tanto lavoro da fare. Abbiamo intrapreso un percorso e siamo solo a metà, non abbiamo vinto la battaglia.
Roberto – Il Progetto Calamaio nasce proprio dal desiderio di intervenire a livello culturale. Ci rendiamo conto che rispetto a venti anni fa le cose sono molto cambiate. Nelle scuole si vedono delle carrozzine, è facile che un alunno abbia un compagno disabile. Ciò non toglie che il cammino sia ancora lungo, anche perché troppo spesso il bambino disabile a scuola è integrato solo formalmente, non realmente, in quanto vive più al di fuori della classe che dentro. Questo perché manca un’accettazione reale del limite: il disabile tira fuori la difficoltà di tutti ad accettare i propri limiti e ciò ti tocca nel profondo…
Stefania – Sconvolge l’ambiente che ti circonda, compreso un parco!
Matias – Apprezzo moltissimo il lavoro fatto dal parco perché permette ai bambini di scavalcare la disabilità.
Roberto – Bisogna riconoscere che in generale sono stati fatti molti passi avanti, anche a livello di servizi. Esistono però ancora delle barriere culturali. Io stesso lo devo riconoscere per primo. Lavoro ormai da tanti anni con la disabilità: ho sempre lavorato con bambini con problemi mentali e non mi ero mai approcciato con la disabilità fisica, avevo una difficoltà personale a farlo.
Quando sono entrato nel gruppo ho dovuto perciò intraprendere un mio percorso e andare nelle scuole mi ha permesso di capire quanto i bambini siano più recettivi.
FV – Non c’è bisogno di dire che è stata un’esperienza positiva.
Roberto – Per noi è stata un’esperienza molto interessante perché il rischio di fare un lavoro, anche divertente e creativo come questo, è che dopo venti anni sei sempre a dire le stesse cose per quanto ci sia necessità…
Stefania – E a fare le stesse cose.
Roberto – Dopo un po’ c’è il rischio di chiudersi. Al contrario queste esperienze ti obbligano a uscire, non dimenticando il proprio passato, ma reinventandolo e ricontestualizzandolo ogni volta. Il contatto con i bambini ci ha consentito di mettere la disabilità in secondo, ma anche in terzo, quarto piano perché prima di tutto c’erano la natura e la storia, e solo in fondo, Stefania sulla carrozzina o Matias che parla in modo un po’ strano.
Stefania – E non nella solita aula che ormai conoscono a memoria!
Salutiamo Roberto, Stefania, Matias e Daniela.
Donatella Stinga